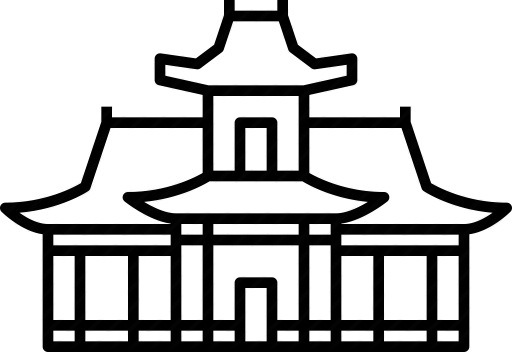Ėrgėž irėhgüj namar • Mongolia, 2022 Regia di Balžinnâm Amarsaihan
mymovies: Ma davvero è possibile appassionarsi ad un film girato in Mongolia, in mezzo a pianure interminabili, e senza neanche una battaglia, uno scontro epico, senza neppure Gengis Khan, ma solo alcuni personaggi di poche parole, quasi tutti con la faccia di Jack Palance cotta dal sole, e tanta tanta erba, cavalli, pecore, tende, silenzi?
Sì , è possibile. Anzi: ne L’ultima luna di settembre, portato in Italia da Officine Ubu, ti sembra di ritrovare il respiro dei grandi western, ti sembra di vedere l’unico western possibile al giorno d’oggi. E ti sembra di cogliere, di nuovo, i sentimenti del Monello di Chaplin, esattamente cento anni dopo. O di Ladri di biciclette (guarda la video recensione). Qualcosa di forte, raccontato con attenzione, con delicatezza. Ma anche con quella forza assoluta, quella innocenza che il cinema occidentale ha perduto da tempo.
Già la prima inquadratura è memorabile, impensabile: un uomo, in piedi su un cavallo, che cerca di tener su un palo. Su un carretto, sotto, un uomo anziano, sdraiato. Che cosa stanno facendo? Perché? Issato su quel palo c’è un vecchio telefono cellulare. L’uomo in piedi sul cavallo sta cercando di alzare il telefono fino all’unico punto, in quell’immenso spazio, in cui riesce a trovare campo. La telefonata alla fine arriva. Raggiunge un uomo che vive in città: forse Ulan Bator, forse altrove. Una voce gli urla di venire subito: un uomo sta morendo. L’uomo che ha fatto da padre alla persona che vive in città.
È la storia di un ritorno, un ritorno alle radici: un po’ come il ritorno di John Wayne in Un uomo tranquillo. Ma per il protagonista che torna a casa, nel suo villaggio natale, non ci sono ragazze irlandesi dal carattere forte. C’è un ragazzino, faccia da scugnizzo orientale, pochi anni e tanta grinta. Un ragazzino che si atteggia a duro, ma a malapena riesce a montare su un cavallo. Un ragazzino che ha imparato a fare la lotta, ma non a leggere e a scrivere.
Ci vuole tutto il tempo necessario, affinché fra l’uomo robusto, taciturno, dalle spalle larghe e il ragazzino vivace, orgoglioso, impertinente si sviluppi un rapporto di confidenza, di lealtà, di affetto. Sono due orfani, l’uomo e il ragazzino di dieci anni. Tutti e due hanno imparato a cavarsela: ma solo uno dei due sa inghiottire grandi sorsate di solitudine senza un lamento, senza una parola.
Per chi ha fame di dati, siamo nella provincia dell’Hentij, una delle più desertiche della Mongolia. Nel film, tratto dal romanzo breve “Tuntuulei” di T. Bum-Erden, il protagonista adulto è interpretato dallo stesso regista, Amarsaikhan Baljinnyam. Il quale è un regista al suo esordio, sì, ma come attore è ampiamente conosciuto: è una star del cinema d’azione mongolo, ha vinto nel 2012 il premio come miglior attore ai Mongolian Academy Awards, e fra il 2014 e il 2016 ha preso parte alla serie originale Netflix Marco Polo. Il bambino, che nel film si chiama Tuntuulei, ha dieci anni e si chiama Tenuun-Erdene Garamkhand.
È una storia d’affetto, una storia di rapporti umani che crescono, e che non vengono raccontati o definiti dalle parole, ma vengono sillabati dai gesti, dai silenzi, dalla semplice vicinanza. È la storia di due persone sole, in una Mongolia rurale che assomiglia a una riserva di nativi americani: anziani pieni di rughe, e adulti preda dell’alcool. Mentre il nuovo avanza, nella forma di un macchinario agricolo.
Mentre si alternano campi lunghissimi, orizzonti che tagliano il due il fotogramma, e primi piani attenti ma non invadenti – difficile spiegarlo: viene quasi da parlare di “rispetto” verso gli attori – non c’è niente che ci prenda per mano. Neanche la musica fuori campo: solo il suono di un’armonica, suonata dal protagonista, Tulgaa, e comprata a caro prezzo dall’uomo che gli ha fatto da padre: “L’ho scambiata con due pecore”.
È un film scarno, eppure complesso, per tutto quello che ci fa percepire, nell’universo del non detto. Un film che rasenta il documentario, mentre racconta un mondo rurale che sembra scolpito nei secoli, ma probabilmente è prossimo alla fine. Ma anche un film capace di scavare nell’anima dei suoi personaggi, di quelle due vite sull’orlo di diventare un nucleo familiare. Ci dice, se mai un film lo ha detto, che cosa sia voler bene, che cosa sia aggrapparsi a qualcuno, per non sentirsi soli nell’universo. Che poi l’universo abbia le sembianze di una pianura infinita che si chiama taiga, è solo un caso.